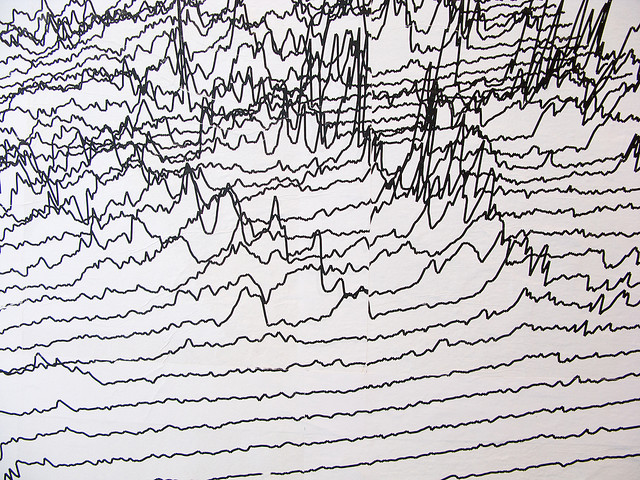
1. «Il mondo è tutto ciò che accade». Partiamo da Oakland.
Il 2 novembre è iniziata una nuova epoca per il movimento #occupy e, più in generale, per gli indignados. All’occupazione delle strade e delle piazze ‒ sul modello spagnolo e di Zuccotti Park ‒ si è accompagnato uno sciopero generale di potenza straordinaria. Bloccato il porto, fermi gli uffici pubblici. Fermi i trasporti su gomma e la produzione. A braccia conserte anche la polizia. E poi decine di migliaia in piazza, a presidiare la città, a consolidare la paralisi del porto.
Guardiamo ad Oakland come si guarda ad un prototipo. Lacunoso, indubbiamente, in parte immaturo, eppure in grado di mettere in forma, in modo temporaneo, il conflitto che serve, quello in grado di fare i conti con la nuova composizione del lavoro e con la violenza della finanza. Non è
sufficiente il sindacato, infatti, ad organizzare un lavoro frammentato e fortemente precarizzato, da sempre immerso nei flussi comunicativi o costretto a prestazioni di tipo neo-servile. Se lo sfruttamento contemporaneo si disloca anche e soprattutto sul terreno dell’accumulazione finanziaria, la lotta di classe deve investire per intero la riproduzione sociale, la vita, la cooperazione extra-lavorativa. Ma non basta neanche il movimento #occupy. La sua forza esibisce la crisi della democrazia liberale di fronte all’arroganza della dittatura finanziaria, ma ancora non ci mostra il modo utile per «far male ai padroni». È necessario prendere la parola e cominciare a «dire la verità al potere», ma bisogna individuare il potere nelle maglie dello sfruttamento metropolitano,nel furto di plusvalore.
In questo senso Oakland è un prototipo, in questo senso riscopriamo, senza timidezza, la nostra ispirazione repubblicana.
2. In Europa la democrazia liberale è finita. L’alternativa cresce fuori dalla gabbia della rappresentanza in crisi.
Un nuovo bonapartismo, una vera e propria «dittatura commissaria» ha fatto il suo ingresso nella scena, con Monti e Papadimos, con «Merkozy», le telefonate della Cancelliera a Napolitano e le letterine della Bce. Mentre scriviamo, non è per nulla certo il futuro dell’euro. Sembra evidente, però, che i mercati finanziari stiano utilizzando la crisi dei debiti sovrani per imprimere un’accelerazione senza pari allo smantellamento del welfare (di cui in Italia lo stesso Presidente della Repubblica si fa abusivo ispiratore e fervente garante), alle privatizzazioni e, soprattutto, stiano sospendendo la sovranità degli Stati, in materia economica e in certi casi anche nella composizione dell’esecutivo. L’estensione delle funzioni della Bce (la possibilità cioè di stampare moneta e di essere prestatrice di ultima istanza) e l’istituzione degli eurobond sarà accompagnata – così come chiede la Bundesbank – da un vero e proprio processo di demolizione della democrazia rappresentativa. I parlamenti nazionali sono già completamente esautorati, laddove i governi si limitano ad eseguire le indicazioni imposte dagli hedge fund e, successivamente, dalla Bce. Monti, figura del tutto interna all’élite finanziaria transnazionale, sta facendo dell’Italia un laboratorio privilegiato della Grosse Koalition, vero e proprio modello di governamentalità (nel suo rapporto con la rappresentanza parlamentare) imposto dalla nuova costituzione materiale.
In questo contesto, europeo e in secondo luogo nazionale, pensare alla rappresentanza politico-parlamentare come luogo dove far crescere la potenza dell’alternativa è un errore oltre che un’ingenuità. Ciò che davvero manca, l’unica cosa che può fare la differenza, è la conquista di un rapporto di forza favorevole con il capitale finanziario e i suoi istituti, e solo i movimenti radicali possono contribuire a determinarla. Si tratta di andare oltre la tradizionale separazione tra sociale e politico: è assumendo fino in fondo il carattere post-democratico della governance finanziaria che pensiamo in termini intimamente politici e costituenti i movimenti europei. Movimenti costituenti, dotati di intelligenza programmatica e capacità istituzionale. Non sarà facile, ma sappiamo che è ciò che serve, ciò per cui vogliamo spendere le nostre energie, la nostra immaginazione, tutta la nostra forza.
3. La nuova governance europea impone al movimento un rinnovato discorso sul rapporto tra conflitto e istituzioni politiche. Nasce il Federalist del tempo presente.
Ci viene in soccorso Foucault con i suoi corsi sul neoliberalismo. Come leggere altrimenti la crisi dell’Europa e dell’euro? L’ossessione tedesca per la stabilità dei prezzi e la «disuguaglianza necessaria» ci ricorda la genealogia del discorso neoliberale minuziosamente ricostruita da Foucault al Collège de France. E anche in questo caso, come per gli Ordoliberali tedeschi nel 1948, si tratta di costituire e legittimare lo spazio politico (quello continentale) a partire dalle esigenze del mercato e della moneta. In questo senso l’austerità imposta dalla Bundesbank configura un salto di qualità rispetto alla fragile governance europea fin qui conosciuta: una nuova «governamentalità attiva» si presenta nella costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, nella cancellazione de facto delle costituzioni democratiche del ’900, nelle privatizzazioni, nelle sanzioni contro i paesi che spendono troppo per scuola e ospedali, nella distruzione del diritto del lavoro. Di fronte a tutto questo il discorso antagonista rischia di girare a vuoto.
È possibile immaginare un nuovo discorso anche rispetto al rapporto tra movimenti e istituzioni politiche? La scelta extra-parlamentare porta con sé la litania rancorosa di sempre? No, di questo siamo certi. Anziché rassegnarsi all’afasia, occorre estendere smisuratamente la propria capacità negoziale: solo un movimento autonomo e radicale può portare con sé la forza necessaria per negoziare con i nuovi istituti della governance finanziaria! È necessario anche capire quali sono gli spazi istituzionali che più favoriscono l’espansività dei movimenti e la loro intensità costituente.
Oltre a tenere lo sguardo fisso sull’Europa, perché è sul terreno continentale che si gioca la partita della costituzione materiale, è opportuno soppesare con intelligenza e spregiudicatezza i dispositivi politico-amministrativi laddove questi sono in grado di mettere in crisi il «monopolio politico della macchina di partito». Con Luciano Ferrari Bravo pensiamo ancora che sia il party-government uno degli avversari privilegiati di una politica di movimento robusta e non subalterna e che sia il federalismo municipale il campo istituzionale che può essere interrogato da un’iniziativa non balbettante di riappropriazione democratica. È con questo spirito che abbiamo guardato con interesse al meccanismo delle primarie: ci sembrava che lì si annidasse, seppur lacunoso, un primo meccanismo di frantumazione del monopolio politico dei partiti. Al di là di alcuni interessanti cambiamenti locali, quella strategia si è rivelata una foto miseramente sbiadita nel disastro della sinistra di sempre.
Un’altra ispirazione potente si accompagna a quella repubblicana: l’ispirazione federalista.
4. Rifuggire il piano della rappresentanza politica non significa intonare il ritornello da organetto della rottura insurrezionale. Occorre, piuttosto, insistere sul carattere costituente (o istituzionale) dei movimenti.
L’insurrezione ha riconquistato diritto di cittadinanza in una parte consistente del pensiero critico, mentre viene rilanciata senza sosta (come un disco incantato) dalle componenti anarchiche del movimento. Nella crisi sistemica del capitalismo, sull’onda emotiva e politica delle grandi rivolte del mondo arabo, sembra realistico cantare le lodi della prospettiva insurrezionale, ogni volta che le macchine prendono fuoco in strada. Eppure c’è qualcosa nel discorso e nella pratica insurrezionalista che ci lascia insoddisfatti. In primo luogo l’insurrezione si presenta sempre – eoccorre rivolgere lo sguardo alle insurrezioni che ci sono o che avvengono, non a come vorremmo che fossero o, normativamente, a come dovrebbero essere – con le fattezze di un «potere destituente» incapace di produrre nuove forme di vita, nuovi dispositivi organizzativi, istituzioni finalmente non più statali. In secondo luogo l’insurrezione, soprattutto nei soggetti che la scimmiottano, rivela un forte mimetismo con la logica statale, meglio, con quella poliziesca. In Italia, per esempio, il segno ACAB (All cops are bastards) ha smesso di essere un ovvio corollario delle rivolte di piazza, ma agli occhi di taluni sembra essere il cuore del programma politico.
Questa logica, ne siamo convinti, non è all’altezza dei problemi che si trovano di fronte oggi i movimenti che insistono sulla trasformazione radicale dell’esistente. Non c’è «assalto al cielo» capace di efficacia, quel che conta è la creatività istituzionale dei movimenti.
Cos’è un’istituzione non statale (o istituzione del comune), che diffonde il potere invece di concentrarlo? Indubbiamente lo sono le forme di organizzazione che abbiamo visto all’opera nel movimento degli indignados, in Spagna, o anche nel movimento #occupy, negli Stati Uniti; i movimenti che si battono per i beni comuni in Italia, dalla vittoria referendaria della scorsa estate alle occupazioni del Cinema Palazzo e del Teatro Valle a Roma; le tante insorgenze studentesche e giovanili che stanno disseminando ovunque – in Europa come nelle Americhe – nuove forme di organizzazione della didattica e della ricerca, più in generale un diverso modo di vivere all’interno degli atenei e delle scuole; le strutture sindacali non concertative. Si tratta di esperienze parziali, grazie tante, ma che nella loro parzialità esemplificano la prassi di istituzioni non statali, di dispositivi biopolitici che, mentre innescano e alimentano il conflitto, consolidano forme di vita, saperi, linguaggi e strumenti comunicativi di nuova natura.
5. Chiamiamo tumulto la forma del conflitto adeguata all’attuale predominio della governance finanziaria.
Facciamo ricorso ad una categoria pre-moderna e machiavelliana, con l’intenzione chiara di trovare nomi che sappiano dar conto della qualità delle lotte laddove si esaurisce il primato della sovranità statuale. Ci pare infatti che la categoria di tumulto, assai meglio del miraggio insurrezionale, sappia dar conto delle nuove pratiche politiche dei movimenti, a cominciare dai riots metropolitani, fenomeni indubbiamente ambivalenti, ma non per questo indegni di una appassionata riflessione politica. Il tumulto è molteplice, per conformazione e composizione. Non è un conflitto puramente destituente, è piuttosto (o ambisce ad essere) un conflitto dove prevale la spinta costituente. In questo senso – e con spirito sinceramente repubblicano – leghiamo la tematica del tumulto a quella delle istituzioni non-statali: tra tumulto e istituzioni c’è un rapporto co-estensivo e ricorsivo nello stesso tempo.
6. L’attualità della rivoluzione va riproposta a partire dal concetto di tumulto, contro l’ipotesi insurrezionale.
Il carattere costituente dei movimenti impone una riflessione impegnativa sul tema della trasformazione radicale, o, senza diplomazie, sulla rivoluzione. Nel tempo della governance, quando l’ordinamento giuridico si frammenta e l’esercizio del comando assume forma reticolare, distendendosi lungo la pluralità dei processi amministrativi, la rivoluzione, così come è stata intesa nella modernità, dice troppo e, nello stesso tempo, troppo poco.
Troppo perché continua a presupporre il tratto omogeneo e unitario del soggetto antagonista. Abbiamo imparato in questi anni che l’egemonia del lavoro cognitivo, sul terreno della composizione tecnica di classe, non fa dei lavoratori della conoscenza il soggetto capace di riassumere su di sé, in termini sia estensivi che intensivi, lo scontro capitale-lavoro. Capitalismo cognitivo, nuovo paradigma della sussunzione della società al capitale, significa fino in fondo irriducibile molteplicità ontologica. È questa molteplicità a rendere impossibile l’omogeneità della figura proletaria e del soggetto antagonista.
Per gli stessi motivi per cui dice troppo, la categoria di rivoluzione dice troppo poco: se il capitale, nel suo schizofrenico sviluppo finanziario, disloca lo sfruttamento e il comando sul bios nella sua interezza, la resistenza e il desiderio di libertà non possono non estendersi oltre la soggettività del lavoro, coinvolgendo i processi di cooperazione intelligente, le condotte, la densità etica delle relazioni sociali, l’immaginazione e la creatività linguistica. Già detto in passato? Può darsi, ma oggi le vecchie parole assumono un senso nuovo.
Proviamo a pensare la rivoluzione a partire dal concetto di tumulto. Se la sfida viene presa sul serio emergono in primo piano una serie di evidenze: la rivoluzione si (ri)presenta come processo permanente, perde le sembianze dell’assalto al cielo, si qualifica attraverso la logica dell’alternativa; la rivoluzione non può non essere molecolare, articolata in piani eterogenei, siano essi spaziali, temporali, soggettivi; la rivoluzione non può che coniugare produttivamente dinamiche di exit (di esodo, di «sottrazione intraprendente») a dinamiche di voice (di protesta, di conflitto «molare»).
7. Per chi vive nell’epoca della violenza, il tumulto è la sola salvezza.
Non ci vuole un meteorologo per sapere che viviamo nell’epoca della violenza. L’epoca del Landgrabbing (della razzia di terre da parte delle multinazionali agro-alimentari), l’epoca in cui la violenza dello Stato interviene a difesa del mercato, delle banche e delle monete, l’epoca della guerra globale permanente, avviata da Bush e mai interrotta da Obama. L’epoca in cui l’«accumulazione originaria», con la sua violenza sanguinaria, si è fatta norma, processo permanente. Come leggere diversamente lo sfruttamento selvaggio di milioni di operai in Cina o in India, l’espropriazione dell’intelligenza collettiva attraverso il copyright, della vita attraverso i brevetti? Violenza che diviene «guerra a bassa intensità» nelle metropoli, quando la moltitudine si ribella, quando l’indignazione assedia i palazzi del potere. La violenza di Marchionne e del suo ricatto, delle banche, too big to fail.
Qual è l’unico antidoto alla violenza contemporanea? Il tumulto. In verità il tumulto, se pensato seriamente, ci impone una riflessione sulla violenza. Di più: è possibile immaginare le istituzioni repubblicane senza un discorso sul tumulto e dunque anche sulla violenza? Per noi la risposta è: no.
Questo vuole dire che scegliamo di costruire una forza simmetrica al potere dello Stato o alla violenza della governance finanziaria? Anche in questo caso la risposta è secca: no. Il tumulto si fa beffe delle misure, di tutte le misure: né violento né non-violento, o semmai entrambe le cose assieme (sia violento che non-violento); in una parola, costituente. Cerchiamo di capire meglio che cosa costruisce il tumulto e perché, per esempio, quella del 15 ottobre è stata – nei casi in cui non si è data come resistenza alla violenza poliziesca subita – una violenza impotente ossessionata dalla rappresentazione simbolica e dalla competizione tra gruppi.
Il tumulto unisce e non lacera, innanzitutto i movimenti. Il tumulto non ha forma, ma produce di volta in volta forme differenti (ha valore tanto un sit-in pacifico, ma ostinato e di massa, che la rabbia del 14 dicembre). Non è misurato dal grado di violenza, ma non ossequia all’imperativo morale della non-violenza. Il tumulto è un «atteso imprevisto» e, seppure procede come un atomo che casualmente devia dal percorso dato, è sempre l’esito maturo di una lunga accumulazione di esperienze. Non c’è progressione dialettica, intendiamoci, non stiamo pensando alla Prefazione della Fenomenologia dello Spirito: il tumulto è un salto quantico, un atto creativo, una transizione affettiva, un fatto (il mondo, appunto, è tutto ciò che accade). Eppure esso non è mai separato dalle sue condizioni di possibilità, le quali mostrano tutta la loro forza e la loro chiarezza solo quando il condizionato, il tumulto, si esprime. C’è un Kant che ci piace, è quello della terza Critica: il tumulto è sublime e ci aiuta a fare i conti seriamente con le trame organizzative che abbiamo intessuto, con l’immaginazione politica sviluppata, con i nomi comuni che funzionano e quelli che girano a vuoto.
Il tumulto non è un evento e non chiede, come un evento, «fedeltà». D’altronde di teorie dell’evento, di moda in questi anni, ce ne sono almeno due: la prima confonde l’evento con l’accadimento, la seconda sa che l’evento è il senso (o la potenza) di un accadimento e sa che il senso è una costruzione paziente, e collettiva. Caute!, direbbe Spinoza. Il senso del tumulto non chiede fedeltà, dispone l’orizzonte dell’organizzazione collettiva, del lavoro faticoso, pieno d’amore, che ci vuole per costruire nuove istituzioni.
In una parola: il tumulto è ostile alla purezza. È infedele. È immorale.
8. Il carattere costituente del movimento si esprime tanto nella capacità di inventare nuove istituzioni, quanto nella riappropriazione democratica delle istituzioni del welfare in dismissione.
Occorre intendersi meglio sul tema delle istituzioni (già abbozzato nella tesi 4). Un repubblicano francese, Saint-Just, diceva che per proteggere la Repubblica (e la rivoluzione) occorreva avere «tante istituzioni e poche leggi». L’istituzione è un «modello positivo di azione»: a differenza della legge, che nega il reale per ordinarlo, l’istituzione organizza il reale, sviluppandone la molteplicità. Il sociale è sempre istituzionale (è questo, crediamo,un buon concetto, non esoterico, di biopolitico).È piuttosto la trascendenza sovrana che prova, senza tregua, a rompere la costitutiva politicità del sociale mediante la forza negativa e disgregativa della legge. La potenza disgregativa della legge, d’altronde, è anche quella che ha sostenuto tra il ’500 e il ’600 le enclosures, quel processo (fattuale e normativo) che Marx, in un capitolo ammirevole del Capitale, ha definito «accumulazione originaria».
Quando diciamo istituzione dunque non diciamo Stato, non abbiamo a cuore la legge, non facciamo l’occhiolino alla socialdemocrazia. Una precisazione superflua, forse: ma nell’epoca in cui la purezza è tornata ad essere un valore, è necessario esser cauti, c’è sempre chi è pronto ad impugnarela penna per incassare un applauso come che sia.
Eppure quando pensiamo alle istituzioni non statali abbiamo in mente Occupy Wall Street, ma anche il Teatro Valle, i movimenti universitari di autoriforma o gli ospedali autogestiti in Catalogna. Cosa ci dicono queste esperienze? Ci raccontano della riappropriazione democratica delle istituzioni del welfare, quelle stesse istituzioni dismesse dalle politiche di austerità, prede impotenti del saccheggio finanziario. La sfida delle istituzioni del comune non è la sfida della separatezza: mentre si sostiene l’invenzione e la crescita di istituzioni di nuova natura, è fondamentale riappropriarsi delle istituzioni esistenti e farle funzionare in modo radicalmente nuovo. In questo senso è la natura stessa della relazione di servizio (o del modello produttivo «antropogenetico») che viene messa in questione: la combinazione tra erogazione del servizio – sia esso culturale o medico – e utenza, meglio, le forme della cooperazione produttiva e lo statuto delle competenze professionali, divengono oggetto della pratica politica stessa. La cura, la dimensione riproduttiva messa a lavoro, perde il suo tratto irenico, ne acquista uno conflittuale, indisponibile alle logiche della sussidiarietà (dalla Big Society di Cameron in giù).
Si tratta di ripensare il welfare oltre l’orizzonte della sicurezza sociale, mettendo al centro la cura e la relazione come polemici processi generativi di nuove forme di vita.
La “pratica del comune” non si distingue più, in molti casi, dalla difesa e dalla riqualificazione del pubblico, sia esso l’università o gli ospedali. Il palato raffinato del pensatore bobò, di fronte a questa affermazione, prova orrore. I proletari, per fortuna, hanno le idee chiare.
9. Oggi è l’invenzione di nuove forme di lotta a far emergere elementi utili per il programma politico dell’alternativa.
Come si costruisce il programma politico oggi? Qui ci troviamo di fronte ad un campo ancora tutto da esplorare. Provare a convincere gli altri, o almeno se stessi, che il programma è ciò che, se adeguatamente articolato, cambia di segno le sorti del movimento è l’equivalente di un gioco di prestigio un po’ goffo, sicuramente mal riuscito.
Partiamo da un esempio concreto. La questione del reddito garantito è stata per molti anni una bandiera del pensiero critico e dei movimenti autonomi. Con l’approfondirsi della crisi questa pretesa diviene assolutamente decisiva, prioritaria: conquistare il reddito garantito significa strappare risorse alla rendita finanziaria, istituire una rendita sociale, adeguata alle trasformazioni del mercato del lavoro e alla qualità dei processi produttivi e di estrazione del valore. Sembra tutto chiaro, cristallino, eppure questo tema programmatico fatica a presentarsi come elemento ricompositivo dei conflitti sociali. Possiamo pensare, però, questo tema estraneo agli indignados spagnoli o all’occupazione del teatro Valle? Forse. Invece è proprio il movimento #occupy, quando investe il terreno della produzione e dei servizi, che più di altri pretende il reddito garantito e nestrappa alcuni pezzi importanti, non risolutivi, ma importanti.
Allora torniamo al programma. Solo l’invenzione di concrete forme di lotta e di riappropriazione garantisce la definizione di un programma anticapitalista maturo, è lì che l’immaginazione politica trova espressione adeguata e verifica impietosa. Più che mai la logica diviene induttiva, più che mai la singolarità e la congiuntura organizzano il linguaggio comune.
10. Decisivo è costruire dispositivi organizzativi in grado di coniugare il movimento #occupy e lo sciopero generale. Che cento Oakland sboccino!
Proviamo ad immaginare il modello Oakland in Europa. Sicuramente Puerta del Sol a Madrid, sicuramente il Teatro Valle o il Cinema Palazzo a Roma, sicuramente i tumulti studenteschi inglesi o italiani. Eppure, forse, occorre andare oltre, occorre costruire luoghi di ricomposizione, dispositivi metropolitani in grado di coniugare #occupy e lo sciopero generale.
Una decina di anni fa, prima di Genova, Iww (Immaterial Workers of the World) proponeva le «Camere del lavoro e del non-lavoro». L’intuizione era corretta, i tempi sbagliati, la soggettività immatura. A dieci anni da Genova, dopo l’esplosione in tutta Europa della crisi del debito sovrano e, contemporaneamente, di movimenti giovanili e studenteschi radicali che si battono contro l’austerità, la proposta ritrova tutta la sua forza. Se il nome non va bene, se ne trovi un altro, è il concetto che conta: luoghi di comune organizzazione orizzontale del lavoro precario non sindacalizzato e disperso nel territorio e del sindacato o di frammenti di sindacato non-concertativo e conflittuale. Non si tratta di fare un nuovo sindacato, neanche di celebrare la nascita di un nuovo soggetto politico: piuttosto di assumere il tratto biopolitico del tessuto produttivo metropolitano e, di conseguenza, di organizzarlo, nelle vertenze e nel mutualismo, nella comunicazione e nell’indipendenza. Per fare questo non bastano le Camere del lavoro, non basta l’università, non bastano i centri sociali: è necessario costruire nessi tra questi campi, linee federative che sappiano dare vita a forme stabili di cooperazione politica.
Di fronte alla completa deregolamentazione del mercato del lavoro, alla compressione senza fine del reddito e dei salari, alla privatizzazione selvaggia dei servizi, alla disoccupazione di massa, l’unica chance per i proletari europei è quella di ripensare radicalmente le forme di organizzazione della vita e del lavoro, assumendo che tra i due termini, ormai, non c’è materialmente alcuna distinzione.
11. Prendere congedo dal moderatismo, pensare la democrazia del comune come processo creativo e conflittuale.
Compito dei movimenti radicali europei che vogliono trasformare lo stato di cose presente è quello di prendere congedo dal moderatismo e farlo a pezzi. Oggi il moderatismo ha le vesti dei governi di unità nazionale o della Grosse Koalition. Il senso di colpa per il debito è il suo slogan, assieme alla scelta «sobria» e «responsabile» di chiedere sacrifici ai poveri per donare ai ricchi, alle banche, agli hedge fund. Ma moderata è anche la scelta di quelle forze politiche di sinistra (tutte) che pensano di poter raccontare favole e di coniugare i diktat della Bce con il benessere di tutti.
Il riformismo è davvero senza fiato, tra capitale e forza-lavoro (campo della vita e del linguaggio) non c’è alcun rapporto organico, né tanto meno mediazione possibile. Nell’epoca in cui sparisce la democrazia liberale, la democrazia come processo che connette tumulti e istituzioni è l’orizzonte materiale dell’anticapitalismo. Processo e non forma di governo, singolare produzione di spazio comune, spazio sottratto alla logica del privato e dello Stato. Solo l’istanza egualitaria contro la politica neoliberale: solo quest’istanza fa della democrazia l’avversario più feroce del moderatismo
politico, antidoto alla «sobrietà» dell’ingiustizia. La democrazia del comune, la democrazia dei nuovi poveri, gli unici in grado di creare qualcosa di nuovo. Per dirla con l’esule ebreo e marxista:
«Tra i grandi creatori ci sono sempre stati gli inesorabili che per prima cosa facevano piazza pulita. Volevano cioè avere un tavolo da disegno, e sono stati costruttori».
Scritto da
Marco Bascetta, Claudia Bernardi, Francesco Brancaccio, Guelfo Carbone, Alberto De Nicola, Paolo Do, Chicco Funaro, Fabio Gianfrancesco, Federica Giardini, Augusto Illuminati, Federico Marini, Marina Montanelli, Isabella Pinto, Francesco Raparelli, Maurizio Ricci, Tania Rispoli, Giacomo Salerno, Shendi Veli, Paolo Virno
LUM (Libera Università Metropolitana/ Free Metropolitan University– Roma)
Febbraio 2012


